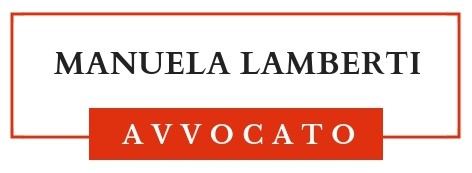1.Diritto della sicurezza sociale: l’assistenza e la previdenza
La previdenza sociale, inizialmente parte del diritto del lavoro, ormai, insieme all’assistenza sociale, costituisce un sistema di sicurezza sociale, definito diritto della sicurezza sociale[1].
La sicurezza sociale può essere vista come la legislazione volta a realizzare un sistema di protezione, al fine di realizzare una delle libertà poste alla base delle moderne democrazie: la libertà dallo stato di bisogno.
È evidente che liberare l’individuo dallo stato di bisogno, significa renderlo libero da rapporti di sudditanza e porlo nella condizione di esercitare pienamente i diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione[2].
La sicurezza sociale ha uno scopo più ampio della protezione del lavoratore, ponendosi l’obiettivo di predisporre una rete di protezione per i cittadini, lavoratori e non e si concretizza in prestazioni di assistenza e prestazioni di previdenza.
Costituiscono assistenza un trattamento o una integrazione ispirati allo scopo di tutelare una situazione di bisogno; sono un esempio di trattamento assistenziale la pensione sociale, la pensione di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento. Rientrano sempre tra le prestazioni assistenziali le cure mediche gratuite. L’assistenza sociale è finanziata dalla fiscalità generale.
Le prestazioni previdenziali sono soprattutto costituite da un trattamento pensionistico determinato in base ai contributi versati durante la vita attività di lavoro. Sia i trattamenti pensionistici che le altre prestazioni previdenziali, quali ad esempio indennità di malattia, indennità di maternità, indennità giornaliera per l’inabilità temporanea assoluta, ecc.., vengono erogate dell’INPS o dall’INAIL e sono per il 70% circa finanziate dai contributi o dai premi assicurativi posti a carico di lavoratori e datori di lavoro, mentre il restante 30% è a carico della fiscalità generale.
Richieda un Parere Legale – Clicchi qui
2. Fondamento costituzionale della previdenza sociale ed evoluzione dei modelli utilizzati
Come accennato nel paragrafo precedente, il diritto della sicurezza sociale trova un primo fondamento nell’articolo 2 della Costituzione repubblicana. Tale disposizione detta, tuttavia, un principio generale che viene riempito di contenuto in altre disposizioni costituzionali. Per quanto concerne lo specifico aggancio costituzionale della previdenza sociale, non possono esserci dubbi che questo si ritrova nell’art. 38, comma 2 della Carta.
In particolare, la norma sopra citata espressamente recita: “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
Il legislatore costituzionale ha dunque previsto gli ambiti in cui opera la previdenza.
È evidente che lo scopo della previdenza sociale è quello di garantire al lavoratore, non inteso soltanto come lavoratore subordinato[3], un reddito per quei periodi in cui non possa lavorare per cause indipendenti dalla sua volontà.
Tale norma ha l’evidente obiettivo di garantire una vita dignitosa al lavoratore anche nei periodi in cui non è in grado di procurarsi un reddito con il suo lavoro.
L’obbligo contributivo è quindi inderogabile e il diritto del lavoratore che gli vengano versati i contributi è un diritto indisponibile, ossia è un diritto al quale il lavoratore non può rinunciare.
Se la costituzione ha fissato il diritto alla previdenza in modo intangibile, ha però lasciato libero il legislatore ordinario di scegliere le modalità di funzionamento del sistema previdenziale. Anzi, mentre la formulazione inizialmente proposta collegava il diritto alle prestazioni previdenziale al lavoro svolto[4], la formulazione finale ha eliminato tale rapporto proprio per lasciare libero in futuro il legislatore di adottare sistemi diversi da quello mutualistico, in vigore al momento dell’approvazione[5]. In effetti, il passaggio da un regime mutualistico ad un regime solidaristico[6] si è concretizzato con il DPR 488/1968.
Più recentemente, ha avuto un considerevole impatto l’introduzione del sistema contributivo in luogo di quello retributivo.
Con il sistema contributivo, la pensione viene calcolata, avendo come riferimento il parametro del montante contributivo individuale, mentre con il sistema retributivo, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi[7].
3 Ruolo dell’avvocato
Il diritto a poter godere del sistema previdenziale e il corrispondente obbligo contributivo può generare conteziosi sotto differenti profili.
Oltre all’ipotesi più estrema di manodopera assunta totalmente in nero, dove difficilmente vi è un interesse del lavoratore a non essere regolarizzato, e dove il datore di lavoro è ben consapevole di commettere un illecito, spesso si verifica la fattispecie concreta in cui lavoratore e dipendente si accordano, con reciproca soddisfazione, per la corresponsione di un superminimo o degli straordinari “fuori busta”. Qualora queste situazioni emergano in sede di ispezione o di contenzioso, sia datore di lavoro che lavoratore dovranno corrispondere la quota contributiva a loro carico, oltre le sanzioni.
Inoltre, in sede ispettiva è piuttosto frequente che vengano contestati inquadramento, rimborsi spese, disconosciuti contratti di collaborazione a vario titolo. In tutte queste ipotesi, saranno calcolati i contributi dovuti, secondo l’Istituto, nonché le relative sanzioni.
Ancora, non può essere dimenticato il caso di imprenditori al quale, a seguito di accertamento, l’Agenzia delle Entrate recuperi delle somme a reddito, con conseguente notificazione da parte dell’INPS dell’avviso di addebito, per contributi e somme aggiuntive calcolati sulle somme recuperate.
In tutte queste ipotesi, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro è fondamentale il supporto di professionisti competenti.
All’attività del consulente del lavoro, certamente fondamentale a monte per evitare di incorrere in errori dai quali possono scaturire sanzioni elevate, si deve affiancare l’assistenza dell’avvocato, nel momento in cui si rende necessario procedere in via giudiziale in opposizione ai provvedimenti dell’Istituto previdenziale.
Richieda un Parere Legale – Clicchi qui
→ Consulenza Avvocato Manuela Lamberti nell’ambito del Diritto Previdenziale | Torino e (Mondovì) ←
- Obblighi contributivi e assistenziali
- Obblighi di comunicazione in caso di instaurazione/cessazione dei rapporti di lavoro e/ocollaborazione
- Assistenza in procedure avverso verbali di ispezione, ordinanze ingiunzione e avvisi di addebito
- Assistenza davanti all’Autorità Giudiziaria e agli organi amministrativi
NOTE
[1] Tale espressione è stata usata a livello normativo per la prima volta dalla legislazione statunitense, con il c.d. Social security act, del 1935.
[2] Art. 2 Costituzione “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
[3] Da qui deriva l’obbligo contributivo di tutti i lavoratori, anche autonomi.
[4] Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione, art. 34, co. 2: I lavoratori in ragione del lavoro che prestano, hanno diritto che siano loro assicurati mezzi adeguati per vivere in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
[5] LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ILLUSTRATA CON I LAVORI PREPARATORI DA VITTORIO FALZONE, FILIPPO PALERMO, FRANCESCO COSENTINO DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI CON PREFAZIONE DI VITTORIO EMANUELE ORLANDO, COLOMBO IN ROMA VIA CAMPO MARZIO 1949, PAG 80 Nel secondo comma rispetto al progetto furono abolite le parole « in ragione del lavoro che prestano », perché, secondo il proponente on. Laconi, « il legislatore futuro abbia una libertà più ampia e possa adottare I criteri che gli appariranno più adatti alla situazione e più efficaci », e per non costringere la futura legislazione in materia di previdenza e assicurazione sociale a seguire soltanto i criteri “di assistenza mutualistica” che sono oggi in vigore.
[6] Sulla differenza tra sistema mutualistico e solidaristico, può essere richiamata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 34/1986, laddove afferma che “…il primo è caratterizzato dalla divisione del rischio tra coloro che sono ad esso esposti e dalla conseguente riferibilità ad essi dei fini e degli oneri previdenziali conseguenti alla stessa divisione, nonché dalla proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali private.
L’altro sistema, che, peraltro, fa perno sugli artt. 2 e 38 Cost., invece, è caratterizzato dalla riferibilità dei fini e degli oneri previdenziali ai principi della solidarietà secondo il modello della sicurezza sociale, sia pure operanti all’interno di ciascuna categoria di lavoratori, nonché dalla irrilevanza della proporzione tra contributi e prestazioni.
Le prestazioni sono considerate lo strumento per l’attuazione dei fini della previdenza in rapporto allo stato di bisogno ed alle esigenze di vita dell’assicurato nel senso innanzi specificato.
I contributi sono i mezzi finanziari della previdenza sociale e sono prelevati in parte dai datori di lavoro e dagli stessi lavoratori delle diverse categorie appunto per assicurare a tutti le prestazioni”.
[7] Per maggior dettagli sulle modalità di calcolo, nonché sul c.d. sistema misto cfr. https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=49949#h2heading31003.