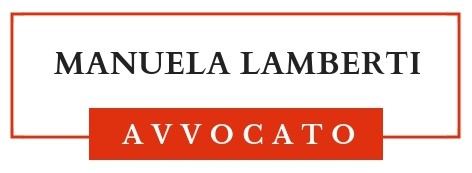Cos’è la compartecipazione agraria
È un contratto con il quale un imprenditore agricolo (concedente) mette a disposizione un fondo per coltivarlo insieme ad un altro imprenditore (compartecipante), allo scopo di dividere i prodotti ottenuti. Si tratta dunque di un contratto associativo.
Il contratto di compartecipazione è un contratto atipico, cioè non disciplinato in modo organico dalle leggi dello Stato. Unico riferimento normativo si rinviene nell’art. 56, L. 203/1982, laddove si afferma che “le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria”.
Tale contratto rappresenta una forma congiunta di esercizio dell’attività agricola (art. 2135 C.C.), prevedendo che due imprenditori agricoli si accordino per utilizzare i propri fattori produttivi per svolgere una coltivazione a carattere stagionale.
A differenza degli altri contratti agrari oggi vietati, quali mezzadria, colonia parziaria, nel contratto di compartecipazione prevale l’elemento di cogestione dell’attività rispetto alla pura prestazione lavorativa.
Al fine di inquadrare correttamente il contratto e non correre il rischio di un suo disconoscimento è necessario che il contratto rispetti i seguenti requisiti: la natura associativa, il carattere parziario, e la brevità o precarietà del rapporto.
Questo contratto rappresenta un modello di cooperazione un tempo diffuso ed ora tornato in auge.
Richieda un Parere Legale – Clicchi qui
I contraenti
Entrambi i contraenti devono essere imprenditori agricoli, altrimenti si configurerebbe un contratto di altra natura.
È necessario svolgere l’attività agricola anche in maniera autonoma
Il compartecipante, oltre a coltivare il fondo del concedente in forma associata, dovrà svolgere anche l’attività agricola in proprio e, conseguentemente, detenere terreni a titolo di proprietà e/o affitto. Inoltre, il compartecipante che partecipa attivamente ai lavori colturali e alla loro organizzazione dovrà essere iscritto nella gestione INPS quale CD o IAP.
Natura associativa
È necessario che entrambe le parti partecipino effettivamente alla coltivazione associata del fondo, dando vita ad una cogestione dello stesso con partecipazione di entrambi al rischio di impresa, senza tuttavia costituire una società.
Pertanto, è necessario che entrambe le parti sostengano le spese di coltivazione e che entrambe eseguano opere colturali sul fondo; la ripartizione del prodotto dovrà essere proporzionale all’effettivo apporto alla conduzione associata. Ad esempio, il concedente potrà sostenere le lavorazioni preliminari alla semina o trapianto (aratura, sistemazione del terreno e prima concimazione), mentre il compartecipante potrà eseguire personalmente o per mezzo di contoterzisti alcune delle operazioni colturali dalla consegna fino al raccolto.
Il rispetto di quanto sopra permetterà di evitare che il contratto venga qualificato come contratto di lavoro subordinato o contratto di locazione.
L’eventuale remunerazione sarà rappresentata dalla ripartizione del prodotto.
Ripartizione del prodotto
Il prodotto dovrà essere ripartito tra concedente e compartecipante in relazione all’apporto che ciascuna parte avrà profuso nella coltivazione congiunta del fondo.
La valutazione di tale proporzione è rimessa alle parti, che nel contratto sono libere di indicare la percentuale da esse scelta. Affinché, il contratto di compartecipazione non sia disconosciuto è necessario che non preveda compensi fissi, predeterminati, essendo questo un modo di aggirare il requisito rischio di impresa.
La suddivisione del prodotto avviene in campo, dopo la fase di raccolta. Il prodotto è attribuito a titolo originario e le parti sono libere di commercializzarlo o consumarlo nella propria azienda.
Conseguenza dell’attribuzione del prodotto a titolo originario, i proventi derivanti dalla vendita di tali prodotti saranno riconducibili alla determinazione del reddito su base catastale ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 del TUIR.
Richieda un Parere Legale – Clicchi qui
Precarietà del rapporto
Il già richiamato art. 56, L. 203/ 1982, fra le varie forme di compartecipazione agraria, esclude dall’applicazione di detta legge, unicamente quella stagionale.
La stagionalità concerne sia l’oggetto del contratto che la sua durata.
Quanto all’oggetto, è stagionale una coltura a ciclo breve, che si alterna con altra coltura sullo stesso fondo. Ne sono un esempio gli ortaggi, ma anche il tabacco o il mais. Certamente non rientrano in questa categoria le piante da frutta, la canna da zucchero o l’erba medica.
In merito alla durata, essa deve essere di qualche mese e terminare con la raccolta del prodotto, al termine del ciclo colturale dello stesso.
Le parti possono stabilire un rinnovo tacito, salvo disdetta da comunicarsi alla parte entro un termine prestabilito. Il rinnovo deve in ogni caso essere circoscritto alla stagionalità della coltura.
Il carattere precario del rapporto si evince dal fatto che il ciclo produttivo della coltura è più breve dell’annata agraria e che nei restanti mesi sullo stesso terreno vengono impiantate altre colture.
La precarietà del rapporto è uno degli elementi che differenzia la compartecipazione agraria dal contratto di affitto. Pertanto ne consegue che il conduttore non può vantare il diritto di prelazione e quindi non può esercitare il riscatto, in caso di vendita del terreno a terzi.
Ulteriori aspetti
La compartecipazione agraria produce i suoi effetti in numerosi aspetti della gestione dell’impresa agricola.
Sotto l’aspetto fiscale, occorre sottolineare che il contratto non è soggetto a registrazione, qualora le parti decidano comunque di registrare il contratto, sarà soggetto a tassa fissa.
Inoltre, come già anticipato il prodotto attribuito a titolo originario è riconducibile alla determinazione del reddito su base catastale.
Trattandosi di un contratto di tipo associativo, si deve procedere alla ripartizione del reddito agrario tra gli associati. Se la quota di riparto non è definita nel contratto, il reddito agrario viene ripartito in parti uguali tra le parti (art. 33, comma 2 del TUIR).
Ulteriori riflessi fiscali concernono la vendita del prodotto.
Le casistiche possono essere le seguenti:
- se il prodotto è ripartito al termine del raccolto, ognuna delle parti decide autonomamente de consumare il prodotto in azienda (es. foraggio per l’allevamento) o venderlo;
- se l’intero prodotto viene venduto da un solo soggetto, possono generarsi situazioni diverse, alcune delle quali potrebbero determinare un parziale indetraibilità dell’IVA, pertanto, prima di accordarsi in tal senso è opportuno consultare il commercialista di fiducia.
Aspetto controverso concerne il contratto di compartecipazione agraria in caso di acquisto agevolato in PPC.
Infatti, nell’ipotesi in cui i terreni messi a disposizione per la coltivazione siano stati acquisiti con le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, l’orientamento maggioritario ritiene che il contratto di compartecipazione, avendo natura associativa, non determini la decadenza dei benefici. Tuttavia, esistono poche pronunce in senso contrario.
In riferimento ai premi P.A.C. è importante che le parti determinino che avrà il diritto di indicare i terreni oggetto di compartecipazione nella domanda P.A.C..
Infine, occorre ricordare che la compartecipazione agraria influisce positivamente sul computo della prevalenza, rispetto alle attività connesse.
Ruolo dell’avvocato
Come visto in precedenza, possono essere numerose le situazioni che possono portare al disconoscimento del contratto di compartecipazione, con conseguente perdita di benefici fiscali, assunzione di responsabilità inattese, instaurazioni di rapporti contrattuali non voluti.
Per evitare ciò è opportuno rivolgersi a professionista qualificato, che sia in grado di guidare gli imprenditori agricoli nella corretta redazione del contratto.
Continua a leggere gli altri articoli correlati al mondo dell’agricoltura (Avvocato Manuela Lamberti):
Richieda un Parere Legale – Clicchi qui