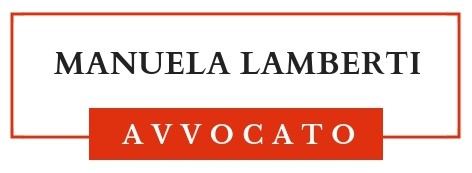1. Cos’è il diritto agrario: cenni
Con l’espressione “diritto agrario” s’intende l’insieme di norme, di diritto privato e di diritto pubblico, che hanno ad oggetto l’agricoltura, in riferimento a soggetti, beni, atti e rapporti giuridici.
Sotto il profilo dell’attività svolta, nel concetto di agricoltura sono ricompresi sia la coltivazione dei campi, sia l’allevamento di animali, inoltre è ormai pacifico che anche la silvicoltura sia da considerarsi attività agricola.
Tuttavia, la definizione giuridica di imprenditore agricolo è più ampia della nozione di agricoltura in senso tecnico. Più precisamente, l’art. 2135 C.C. sancisce che “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse [2082, 2083].
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge [2557][1].
Non solo. La nuova formulazione dell’articolo sopra citato è tale da permettere una interpretazione estensiva, sicché possono essere ricomprese nel concetto di attività agricola connessa, attività che ben poco hanno a che vedere con il concetto di agricoltura in senso tecnico. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che in relazione all’inquadramento nel settore agricolo ai fini previdenziali, l’elencazione delle attività connesse contenuta nel secondo comma dell’art. 2135 cod. civ. (nel testo vigente anteriormente alla riforma operata ex art. 1, d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228, applicabile “ratione temporis”) è meramente esemplificativa, potendosi avere, oltre alle tipiche attività connesse menzionate dalla norma, anche attività atipiche, quali ad esempio la tenuta della contabilità, dietro corrispettivo annuo, per imprese agricole associate[2].
L’art. 2135 c.c. traccia quindi la mappa per l’identificazione dell’imprenditore agricolo, dell’attività agricole essenziali e delle attività agricole connesse.
Richieda un Parere Legale – Clicchi qui
2. I soggetti
È imprenditore agricolo, inteso sia come coltivatore diretto, che come IAP (imprenditore agricolo professionale), il soggetto che svolge l’agricoltura, ossia il titolare dell’azienda agricola.
Sotto il profilo civilistico, in tema di affitto a coltivatore diretto, l’art, 1647 c.c. sancisce che è coltivatore diretto colui che coltiva il fondo prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia[3]. Dunque, il lavoro del coltivatore diretto e della sua famiglia deve prevalere sul lavoro di terzi, comunque prestato, sia esso di dipendenti o meno.
La legislazione per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, con la Legge n. 590/1965, art. 31, stabilisce che sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame.
Se la qualifica di coltivatore diretto civilistica rileva ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle CCIAA, la definizione della legislazione speciale rileva per aspetti particolarmente sentiti tra gli agricoltori, quali la prelazione agraria o l’accesso a prestiti agevolati.
La figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) è stata introdotta con il D.Lgs 99/2004. L’art. 1 di tale decreto sancisce che è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999[4], dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
L’imprenditore agricolo può svolgere la sua attività in forma individuale o associata, costituendo società di persone, di capitali o cooperative agricole[5].
Sotto il profilo previdenziale, coltivatore diretto e IAP sono soggetti a obblighi simili: oltre a versare i contributi per la propria attività, così come determinati dall’INPS ogni anno, devono versare i contributi agricoli unificati per gli operai (OTI e OTD)[6], mentre per impiegati e dirigenti agricoli il premio assicurativo sarà versato all’ENPAIA.
Richieda un Parere Legale – Clicchi qui
3. L’attività
L’attività svolta dall’imprenditore agricolo è, come detto, l’esercizio di un’attività agricola.
Le attività agricole devono essere distinte in attività agricole essenziali e attività agricole connesse.
3A) attività agricole essenziali
Le attività agricole essenziali sono le attività imperniate sul ciclo biologico, o fase di esso, di carattere animale o vegetale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo. Nelle attività agricole essenziali emerge preponderante la centralità della terra, quale fattore produttivo principale su cui l’attività dell’intera azienda si radica. Tuttavia, la nuova formulazione dell’art. 2135 c.c., pur mantenendo la centralità del fondo, non elude le problematiche derivanti dal mutamento dell’agricoltura e con l’espressione “utilizzano o possono utilizzare il fondo”, accoglie nella definizione di attività agricola quelle attività che tradizionalmente legate allo sfruttamento del fondo, possono ora prescindere da esso. Si può dunque dire che vi sia attività agricola ogniqualvolta l’attività svolta sull’essere vegetale o animale ne determina una crescita, qualitativa o quantitativa[7].
3B) attività agricole connesse
Le attività connesse sono quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, così come previsto dall’art. 2135 c.c. Sono quindi attività agricole connesse collegate all’attività principale e volte ad una maggior di valorizzare i prodotti agricoli.
Per essere considerata agricola l’attività connessa deve essere svolta da imprenditore agricolo e deve avere ad oggetto prodotti provenienti prevalentemente dallo svolgimento dell’attività principale. Quindi sarà agricola la trasformazione dell’uva in vino se almeno il 51% dell’uva è prodotto direttamente dal vignaiolo.
Inoltre, sono considerate attività connesse anche le forniture di beni e servizi, purché avvengano utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’azienda agricola. Sarà pertanto attività agricola connessa quella del conto terzista che utilizzi i macchinari necessari all’attività agricola principale anche in favore di terzi, mentre non potrà essere considerata agricola l’attività del contoterzista con attrezzature sovradimensionate, rispetto all’azienda agricola, essendo queste utilizzate prevalentemente a favore dei terzi.
Richieda un Parere Legale – Clicchi qui
4. I rapporti giuridici
Il diritto agrario, oltre a definire chi è imprenditore agricolo e cos’è l’attività agricola, si occupa anche della disciplina inerente ai rapporti giuridici propri del mondo agrario. Ovviamente, il mondo dell’agricoltura si avvale di tutti i contratti normalmente impiegati in qualsiasi settore (vendita, somministrazione, comodato, prestazione d’opera, ecc…). Tuttavia, sono previsti per l’agricoltura diversi contratti specifici, la maggior parte, ormai di fonte normativa, mentre per alcuni permane la fonte consuetudinaria[8]. In considerazione del particolare legame che l’agricoltura ha con il suolo, devono inoltre essere considerati i diritti reali.
4A) i contratti
Sotto il profilo privatistico, i tradizionali contratti agrari[9], dopo la riforma operata con la Legge 203/1982 che ha vietato la stipulazione di nuovi contratti associativi, prevedendone la conversione in contratti di affitto, hanno nel tempo perso di rilevanza, fatta accezione per la soccida (art. 45), ancora molto impiegata nei grandi allevamenti di suini o avicoli.
Il principale contratto agrario attualmente è il contratto di affitto, disciplinato dalla sopra citata legge 203/1982, integrata da successive modifiche che tengono conto dell’evoluzione delle imprese agricole.
Al contratto di affitto, si affiancano, in forza dell’art.56 della menzionata legge, altri contratti che si potrebbero definire “minori”, e precisamente i contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali. Le concessioni per coltivazioni intercalari e le vendite di erbe di durata inferiore ad un anno, quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria.
La caratteristica di tali contratti è quella di permettere una più o meno ampia forma di collaborazione volta al miglior sfruttamento dei fattori produttivi. Tale caratteristica può essere rintracciata in ulteriori forme contrattuali, molto diverse tra loro.
La prima ha fonte consuetudinaria e come tale è radicata solo in alcune zone del territorio nazionale. Si tratta della guardiania, contratto concernente la pastorizia e giunto negli ultimi anni agli “onori delle cronache” in relazione alla sua differenza con il contratto di pascolamento di terzi e le enormi conseguenze che l’utilizzo della prima tipologia contrattuale (ammessa entro certi limiti) ha avuto, rispetto alla seconda (non più ammessa) in punto conseguimento dei premi PAC sui pascoli montani.
Sempre nell’ottica della cooperazione tra imprese agricole, deve essere ricordato il contratto di rete[10] che a partire dall’anno 2014 prevede una disciplina specifica, applicabile alle imprese agricole di piccole-medie dimensioni, la cui caratteristica peculiare è rappresentata dall’acquisto a titolo originario della produzione agricola da parte delle imprese retiste[11].
4B) i diritti reali
L’imprenditore agricolo può essere o meno proprietario del suolo su cui esercita la propria attività. Il legislatore nel tempo ha inteso favorire la possibilità per gli agricoltori di diventare proprietari della terra su cui lavorano. Conseguentemente, il diritto di proprietà[12] del fondo può subire specifiche limitazioni.
È il caso del particolare regime dettato in tema di prelazione sul fondo rustico, prelazione che opera sia nel caso di vendita che nel caso di affitto, ed in conseguenza della quale il proprietario del fondo non può disporre liberamente del proprio bene se prima non assolve gli obblighi imposti dall’istituto cui si è accennato.
Ulteriori limitazioni alla circolazione dei fondi derivano acquisto degli stessi tramite ISMEA, che nel contratto di finanziamento può prevedere l’incedibilità del fondo o l’indivisibilità dello stesso per un determinato numero di anni. O ancora, si possono ravvisare limitazioni alla circolazione dei fondi, in relazione alla PPC (piccola proprietà contadina – in realtà non soggetta a limiti di estensione), per la quale è prevista la decadenza dell’agevolazione, con il conseguente recupero delle imposte e le relative sanzioni, se l’acquirente cede volontariamente i terreni, a qualsiasi titolo, oppure cessa di coltivarli o di condurli direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, impendendo quindi sia la vendita che l’affitto o il comodato del fondo oggetto dell’agevolazione.
Inoltre, analoghe restrizioni sono previste per le attrezzature acquistate con contributi del PRS. Anche in questi casi, per un determinato numero di anni, stabiliti dal bando, tali attrezzature non potranno essere cedute.
Oltre alle limitazioni alla circolazione, cui si è appena accennato, il diritto di proprietà può essere gravato da dritti reali di godimento.
Classico esempio ne sono le servitù. Numerosissimi sono i terreni gravati da diritti di passaggio la cui origine risale a tempo immemore. Più recenti sono le servitù di elettrodotto e gasdotto, il cui interesse è tuttavia in aumento, con il costante sviluppo delle agroenergie.
Sempre legato al settore delle agroenergie, deve essere ricordato il nuovo interesse per la costituzione del diritto di superficie. A tal proposito è opportuno richiamare la recente pronuncia della Corte di Cassazione che chiarisce come in caso di costituzione e cessione a titolo oneroso di diritto di superficie su terreno agricolo, nessuna tassazione sia dovuta sulla plusvalenza, salvo che non siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto[13].
Pur non rientrando in nessuna delle categorie tradizionali, sono qualificabili come diritti reali di godimento anche gli usi civici, i quali possono essere definiti, diritti reali di godimento, come, ad esempio, quelli di seminare, pascolare e abbeverare il proprio bestiame, legnare ecc., per il bisogno proprio o della propria famiglia (usi civici essenziali) o oltre il proprio bisogno (usi civici utili), che gli abitanti di un luogo, (normalmente un comune) esercitano quali appartenenti a quella determinata comunità, sulle terre gravate dall’uso civico. Tali diritti risalgono al Medio Evo e nonostante i numerosi tentativi di superarli, le comunità locali li hanno sempre difesi. Attualmente gli usi civici sono regolati dalla Legge n. 1766/1927 e dalla Legge n. 431/1985, che li ha inseriti nell’elenco dei beni sottoposti a tutela ambientale.
Circa il 70% dei comuni del Piemonte ha porzioni di territorio gravate da usi civici[14].
Richieda un Parere Legale – Clicchi qui
5. Le agroenergie
Per agroenergie, in via di estrema semplificazione, si intende la produzione di energia “pulita” mediante fonti rinnovabili da parte degli imprenditori agricoli.
Per correttamente definire l’ambito di operatività del conetto di agroenergia, si può citare il contenuto dell’art.1, comma 423, Legge 266/2006 (finanziaria 2006), il quale sancisce che “la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.
Dunque, la produzione di agroenergie è attività connessa. Diventa pertanto determinante il soggetto che produce l’energia da fonti agroforestali.
Affinché si possa parlare di agroenergia la produzione dell’energia elettrica o termica deve essere effettuata da un imprenditore agricolo. Conseguentemente, la stessa attività svolta da un soggetto che semplicemente acquisti gli scarti agroforestali, al fine della produzione di energia rinnovabile, non potrà essere considerata attività agricola connessa. Con l’effetto, sotto il profilo fiscale che il reddito non sarà considerato reddito agrario.
Oltre al profilo soggettivo dovrà essere considerato anche il profilo oggettivo, inerente alla problematica della prevalenza.
Oltre all’energia derivante da fonti agroforestali è considerata attività connessa anche la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, purché vi sia un collegamento con l’impresa agricola. Saranno dunque necessari dei terreni coltivati, indicati a catasto rurale, con attribuzione di reddito agrario.
Il concreto svolgimento dell’attività di produzione di agroenergie, implica numerosi risvolti: dalla scelta del soggetto giuridico che svolgerà l’attività in questione, al luogo deve far sorgere l’impianto, la stipula di contratti e convenzioni, sia con soggetti pubblici che privati, l’eventuale assunzione di dipendenti. Per tali ragioni, benché come detto, la produzione di energia da fonti agroforestali sia un’attività connessa si è preferito affrontare la questione in un paragrafo dedicato e di chiusura, poiché trattandosi di una materia di forte innovazione riassume in sé le questioni già trattate e le proietta in un ambito in continua evoluzione.
Richieda un Parere Legale – Clicchi qui
6. Ruolo dell’avvocato
Se la funzione tradizionale dell’avvocato in ambito agrario poteva essere confinata al contenzioso in tema di confini, diritto di prelazione e rispetto dei contratti d’affitto, attualmente, oltre a tali ambiti, comprende la consulenza e l’assistenza che spazia dalla corretta individuazione delle varie forme di collaborazione tra imprese e la relativa redazione dei contratti volti alla loro esecuzione, alla individuazione di quanto possa essere ricompreso nel concetto di attività connessa, dall’interpretazione di bandi di concorso, alla consulenza e assistenza in ambito contrattuale con clienti e fornitori. Per un’ottimizzazione dei risultati, sia nell’ottica di prevenzione dei contenziosi, che di difesa in giudizio, è necessario che l’avvocato sappia interloquire con associazioni di categoria, agronomi, ingegneri e ogni altra professionalità tecnica che curi aspetti rilevanti della vita dell’impresa agricola.
Richieda un Parere Legale – Clicchi qui
→ Consulenza Avvocato Manuela Lamberti nell’ambito del Diritto Agrario | Torino e Cuneo (Mondovì)←
In tale prospettiva, l’avvocato Manuela Lamberti offre consulenza e assistenza nei seguenti ambiti del diritto agrario:
Attività Stragiudiziale
- Consulenza e assistenza in ambito PAC
- Assistenza redazione contratti di rete di imprese
- Consulenza e assistenza nella predisposizione di statuti societari
- Consulenza e assistenza in tema di prelazione
- Assistenza redazione contratti di affitto, soccida, compartecipazione agraria e coltivazioni intercalari
- Consulenza e assistenza in progetti a carattere agroambientale
Attività Giudiziale
- Assistenza nei contenziosi derivanti dall’esecuzione dei contratti agrari
- Assistenza nelle controversie per violazione del diritto di prelazione
- Assistenza nei contenziosi in ambito previdenziale
- Azione monitoria nei confronti degli enti pagatori, relativamente ai premi già liquidati
- Assistenza nel contenzioso relativo a diritti reali di godimento
- Assistenza nelle controversie contrattuali
- Assistenza in tema di responsabilità extracontrattuale
NOTE
[1] Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
[2] Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11707 del 15 maggio 2013.
[3] Cfr. art. 1647 c.c.: Quando l’affitto ha per oggetto un fondo che l’affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono.
[4] Cfr. art. 5, c. 1, Reg. CE 1257/1999: Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole
- che dimostrino redditività,
- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e
- il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.
[5] Cfr. D.Lgs. n. 99/2004 e D.Lgs. n. 228/2001.
[6] Restano escluse dal meccanismo dei contributi agricoli unificati le cooperative di trasformazione di cui alla Legge 240/1984.
[7] Rag. Gian Paolo Tosoni Relazione al Convegno del 27.6.2018 , Torino “Fiscalità in agricoltura: opportunità dei contratti di rete e aspetti fiscali della soccida”
[8] Per la raccolta degli usi e consuetudini della provincia di Cuneo cfr. https://www.cn.camcom.gov.it/it/usi; per la raccolta degli usi e consuetudini della provincia di Torino, il cui aggiornamento risale al 2005 cfr. https://www.to.camcom.it/pubblicazioni/raccolta-provinciale-degli-usi.
[9] Mezzadria Art. 2141. – Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.
Colonia parziaria Art. 2164. – Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.
La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita [dalle norme corporative] dalla convenzione o dagli usi.
Soccida Art. 2170. – Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.
[10] Art. 3, co. 4 ter, D.L. 5/2009 – Più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
[11] A tal proposito cfr. la risoluzione n. 75/E del 21 giugno 2017 dell’Agenzia delle Entrate
[12] Art. 832 c.c. Contenuto del diritto: Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
[13] Corte di Cassazione, Ordinanza 14847/2018.
[14] Per maggiori informazioni cfr. http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/servizi/792-usi-civici-regione-piemonte.